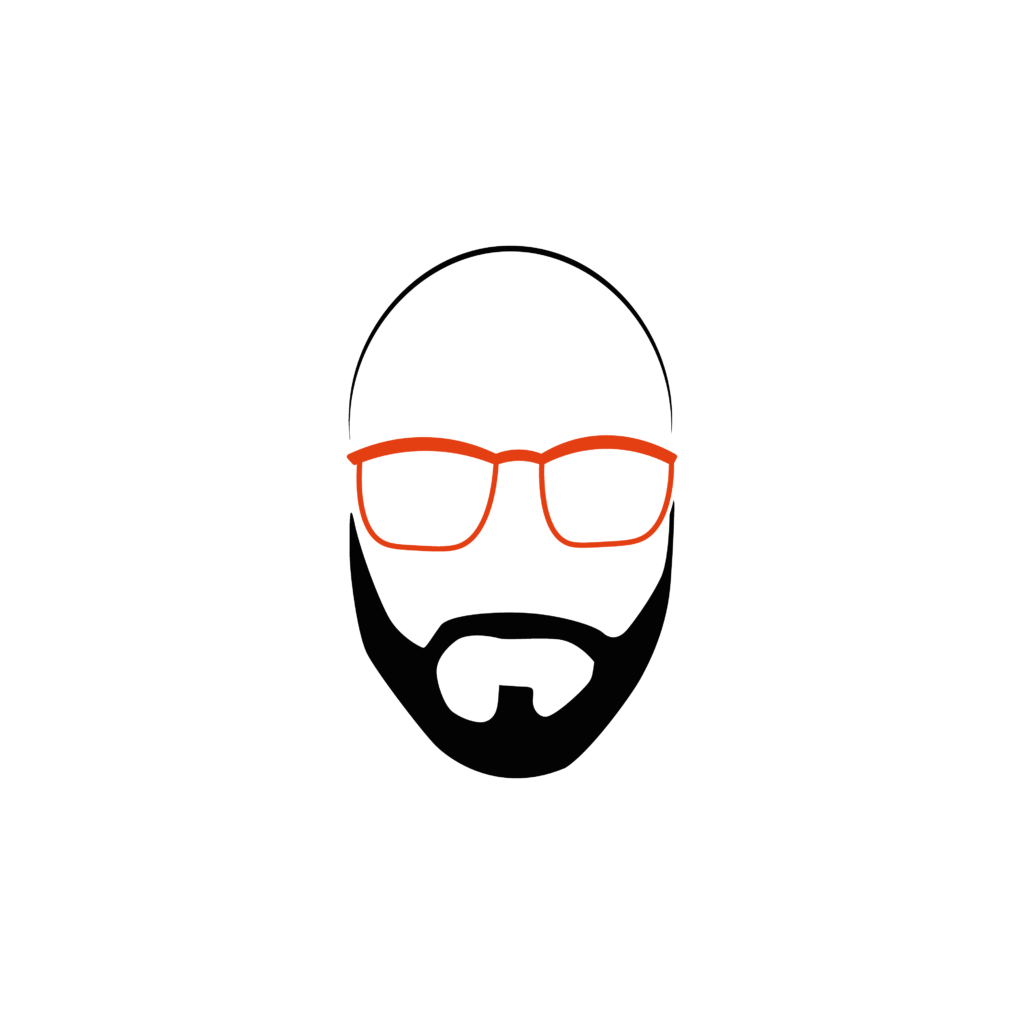Casagit, nuove strategie contro lo stress in redazione: il 79% dei giornalisti ne soffre

Il lavoro dei giornalisti italiani è sempre più caratterizzato da stress psicosociale, carichi cognitivi elevati e incertezza occupazionale. L’indagine “Breaking News”, promossa dall’Osservatorio salute e sicurezza sul lavoro di Casagit Salute, ha coinvolto 1.910 professionisti dei settori stampa, televisione, web e radio, analizzando i rischi del mestiere. Il report sarà discusso al Congresso europeo di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni a Praga dal 21 al 24 maggio 2025. Lo studio, realizzato con il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop) e l’Università di Bologna, evidenzia come il 79% dei giornalisti percepisca un forte aumento dello stress lavorativo. Le principali cause sono il sovraccarico informativo, l’uso incessante delle tecnologie e la riduzione del personale nelle redazioni. Il tecnostress, ovvero la difficoltà nel gestire notifiche continue e l’accelerazione dei tempi di produzione, sta incidendo negativamente sul benessere mentale e fisico dei professionisti dell’informazione. Un altro dato allarmante riguarda la crescente preoccupazione per la sicurezza occupazionale: il 65% degli intervistati teme che l’intelligenza artificiale possa ridurre ulteriormente le opportunità di impiego, mentre l’82% ritiene indispensabile un aggiornamento continuo delle competenze per restare competitivi. La costante pressione nel garantire contenuti rapidi e aggiornati porta inoltre a un calo della qualità dell’informazione, con ripercussioni sia sui giornalisti che sul pubblico. Il report è stato già consegnato alla Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) come contributo al tavolo di discussione per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Secondo il presidente di Casagit Salute, Gianfranco Giuliani, questi dati devono spingere a implementare strategie di prevenzione e supporto per migliorare la salute psicofisica dei giornalisti e rendere il settore più sostenibile. Tra le soluzioni proposte, emergono l’adozione di modelli organizzativi più equilibrati, la promozione di percorsi di formazione continua e un maggiore riconoscimento del valore del lavoro giornalistico.
Trump, la guerra alla “follia woke” e la censura: la lista nera delle parole che vanno abolite

Donald Trump, da sempre sostenitore della libertà d’espressione, si trova ora al centro di un evidente paradosso: mentre proclama la sua battaglia contro la censura, impone drastiche restrizioni sul linguaggio utilizzato nelle agenzie federali americane. Primaonline riporta che, secondo un’inchiesta del New York Times, numerose parole e concetti sono stati eliminati dai documenti ufficiali, dai siti web governativi e dalle linee guida interne, creando una vera e propria lista di termini proibiti. Tra questi si trovano riferimenti all’identità di genere, alla diversità, all’equità e all’inclusione, ma anche espressioni legate all’ambiente, alla giustizia sociale e ai diritti delle minoranze. L’ossessione di Trump per la lotta contro quella che definisce la “follia woke” si traduce in una vera e propria epurazione lessicale, con la volontà di cancellare dall’apparato statale ogni riferimento a tematiche che possano richiamare il progressismo. La parola “transgender”, ad esempio, è stata rimossa, così come “women” e “LGBTQ+”. Anche termini come “cambiamento climatico”, “patrimonio culturale”, “pregiudizi” e persino “discorsi d’odio” sono stati banditi. Una delle decisioni più discusse riguarda la cancellazione del nome “Enola Gay” da documenti ufficiali e foto del Pentagono, per via del termine “gay” presente nel nome del bombardiere che sganciò l’atomica su Hiroshima. La campagna di Trump si estende anche oltre la censura linguistica. Il presidente ha ordinato la sospensione di celebrazioni come il Martin Luther King Day, il Giorno della Memoria e il Pride Month, eliminando qualsiasi riferimento alla diversità, equità e inclusione nei luoghi di lavoro federali. Questa politica ha conseguenze tangibili non solo nel linguaggio istituzionale, ma anche nella vita accademica e scientifica: molte università e enti di ricerca temono la perdita di finanziamenti e si stanno adeguando al nuovo corso. Perfino la NASA ha eliminato dal proprio sito le informazioni sulle donne nel campo STEM, mentre interi dipartimenti di studi di genere, clima e migrazioni stanno chiudendo. L’amministrazione Trump giustifica queste misure come una reazione alla cancel culture, ma in realtà sta praticando una forma selettiva della stessa strategia, eliminando dal dibattito pubblico ogni voce contraria alla sua visione conservatrice. La scelta delle parole proibite non è casuale: riflette una chiara volontà di riscrivere la narrazione sociale e politica degli Stati Uniti, plasmando il linguaggio in modo da eliminare concetti scomodi. Le parole hanno potere e, come sottolinea il New York Times, questa epurazione linguistica è uno specchio delle priorità ideologiche dell’amministrazione. Il caso americano ha anche un’eco internazionale, con paralleli inquietanti. In Argentina, il presidente Javier Milei, sostenitore di una crociata contro il politicamente corretto, ha reintrodotto nel linguaggio istituzionale termini offensivi come “imbecille”, “ritardato” e “idiota” per riferirsi alle persone con disabilità intellettive, oltre a voler eliminare il concetto di femminicidio dal Codice penale. Trump e Milei condividono una visione del mondo in cui il linguaggio deve essere uno strumento di potere e controllo, piuttosto che un mezzo per rappresentare la complessità della realtà. Non è un caso che anche Elon Musk, alleato di Trump, abbia recentemente emulato il leader argentino, brandendo una motosega come simbolo di questa battaglia culturale. Le implicazioni di questa censura vanno oltre la semplice scelta di parole. Eliminare termini come “etnia”, “discriminazione” o “disparità di genere” non cambia la realtà, ma impedisce di affrontarla apertamente, con conseguenze concrete sulla ricerca, sulla politica sociale e sul dibattito pubblico. L’effetto è un arretramento del discorso democratico, in cui la libertà di espressione viene sacrificata sull’altare di una narrativa ideologica sempre più ristretta e autoritaria.